Quando si parla di babywearing si parla (o si dovrebbe parlare) anche di salute, sia del portato che del portatore.
Ci sono pochissimi studi, purtroppo, sul babywearing in sé, per disinteresse, perché l’argomento si sta facendo spazio nel modo di accudimento collettivo solo più di recente o per infattibilità etica, ma, per fortuna, abbiamo come riferimento gli studi posturali sul neonato. Ultimamente leggo con un po’ di apprensione una deriva verso il “è tutto naturale, basta stare addosso”.
Pur sapendo perfettamente il valore del contatto per un bambino, credo che sia importante non sottovalutarne la corretta postura per favorire ed accompagnare un altrettanto corretto sviluppo. In particolar modo se si tratta di neonati entro i primi 3-4 mesi o, a maggior ragione, di neonati pretermine o con bisogni speciali.
Questo articolo è stato scritto in collaborazione e con la revisione di Barbara Vanoli – Osteopata specializzata in osteopatia pediatrica (tanto da far parte dell’equipe dell’ospedale Pediatrico Meyer), di Francesca Gheduzzi, Fisioterapista pediatrica e docente di Massaggio Infantile dell’AIMI e dell’approccio Bobath EBTA e di Elia Carbone, infermiere pediatrico in neonatologia all’Ospedale di Prato ed insegnante di Massaggio Infantile AIMI, che ringrazio infinitamente per il confronto, per la disponibilità e per le integrazioni tecniche.
Posizione generale
La posizione più consona in fascia (ed adatta a tutti ed in tutte le occasioni) è quella verticale. È l’unica posizione che consente al bambino di mantenere una buona cifosi della colonna vertebrale (che nei primissimi mesi è fisiologica in quanto ancora la curva cifotica è l’unica), una corretta divaricazione delle anche e il sostegno della schiena e del torace cosicchè il bambino non “si accartocci” su se stesso e che quindi mantenga libere ed espanse le vie respiratorie, in accordo con le più recenti indicazioni di prevenzione della SIDS (Sudden Infant Death Sindrome o Morte in culla) emanate nel 2016.
Schiena
La schiena deve essere mantenuta in asse, ovvero il bambino non deve “pendere” verso uno dei due lati, la “C” della colonna vertebrale deve essere nitida ma non eccessivamente chiusa perché, se lo è, significa che la schiena non è sufficientemente sostenuta e che, troppo raccolto su se stesso, il bambino avrà difficoltà a respirare liberamente. Un buon elemento di controllo è la posizione della testa che deve essere appoggiata di lato sul petto del portatore con il nasino che punti in diagonale verso l’alto. Con il passare dei mesi ed il raggiungimento degli step di maturazione della colonna vertebrale (la capacità di tenere bene la testa, il raggiungimento della posizione seduta, il gattonamento ed infine la posizione eretta) è necessario cambiare la posizione finale del bambino in fascia per assecondare il naturale sviluppo dell’apparato muscolo scheletrico e delle competenze motorie.
Collo e testa
Il collo deve essere ben sostenuto in modo da consentire alla testa una posizione corretta ma non costretta. Questo si ottiene con la tensione ed il posizionamento corretto della stoffa, non con “stratagemmi” di compensazione.
Ad esempio, nella legatura FWCC (Front Wrap Cross Carry), l’imbottitura del bordo che sostiene il collo può essere utile per ammortizzare il contatto della stoffa con la pelle del bambino, qualora sia particolarmente sensibile, o, in caso di ipotonia più o meno

La testa viene sorretta dalla tensione della stoffa
accentuata del bambino, per contenere e sostenere maggiormente la posizione corretta. Ma in alcun modo può né deve sostituire o compensare una corretta tensione del tessuto, che è in grado di sostenere da solo, in modo fermo ed efficace, la posizione corretta.
La parte posteriore della testolina, specie durante la veglia, non deve essere costretta dalla stoffa perché questo andrebbe ad inibire l’estroflessione naturale del collo, utile per un corretto attacco al seno e per iniziare il processo di sviluppo della muscolatura dorsale. È invece opportuno offrire un eccellente sostegno del collo ed eventualmente contenere la testa con uno dei due lembi durante il sonno, avendo cura che non vada a costringerla.
Per quanto riguarda i bambini ipertonici, il collo è un elemento fondamentale di “sblocco” della posizione tipica dello schema estensorio e di controllo della disorganizzazione motoria. Quindi si cercheranno legature e tipologie di supporti in grado di ridurre la spinta centrifuga e contro-cifotica tipica dell’ipertonia, attraverso un sostegno saldo e sicuro della nuca.
Braccia e gambe
Le braccia devono rimanere flesse, ai lati del torace, con le mani posizionate vicino al viso.

Le manine stanno bene vicino al viso
Una tale posizione, raccolta sull’asse mediano, consente al bambino di gestire al meglio il proprio schema motorio e di ridurre la disorganizzazione motoria. In questa posizione, il neonato è in grado di esercitare consapevolmente la propria muscolatura ed il proprio schema di movimento. La stessa modalità di posizionamento è molto utile anche per i bambini di basso peso alla nascita o nati pretermine. Questi bambini hanno spesso difficoltà ad autoregolare la propria motricità ed i propri stati comportamentali. In questa corretta posizione e nel suo approccio contenitivo e facilitante della motricità, ottengono invece dei buoni risultati in termini di regolazione autonomica e di co-regolazione offerta dal corpo del genitore, ovvero l’opportunità che il genitore fornisce al proprio bambino di potersi stabilizzare, di avere movimenti armonici e di passare da uno stato comportamentale all’altro riducendo i segnali di stress e favorendo quelli di benessere

Le ginocchia sono appena più aperte dell’ampiezza delle spalle
Le gambe devono essere mantenute nella divaricazione fisiologica. Per divaricazione fisiologica non si intende la massima divaricazione raggiungibile dalle gambette del neonato in modo autonomo ma una divaricazione che porti le ginocchia ad una distanza poco più ampia dell’ampiezza delle spalle. Ovvero la posizione che anche da adulti assumiamo quando ci accovacciamo.
Questo è essenziale, come dicevamo per le braccia, per garantire il controllo dello schema motorio con l’allineamento sulla linea mediana e la possibilità di incontrarsi per manine e piedini (che è la base della cura posturale del neonato e soprattutto del neonato pretermine o con bisogni speciali).
La posizione raccolta offre una buona resistenza alla forza di gravità garantendo una posizione attiva, la facilità respiratoria e la stabilizzazione dei parametri vitali, oltre un buono sviluppo psico-motorio.
In posizione prona (come ad esempio sul petto di un genitore sdraiato o adagiato) i neonati tendono ad aprirsi in modo eccessivo. Specie con i bambini prematuri e con i bambini pretermine è necessario contrastare l’extra-rotazione dei cingoli che comporta il rischio di disorganizzazione motoria e di una posizione del corpo non attiva e quindi non funzionale al corretto sviluppo.

Genitore inclinato, bambino in posizione prona

Genitore in piedi, bambino in verticale
Teniamo sempre presente anche che il corpo in posizione prona non subisce lo stesso tipo di sollecitazione gravitazionale di un corpo in posizione verticale: chi fa cura posturale dei neonati, specie dei neonati pretermine, infatti, sconsiglia il prolungarsi nel tempo della posizione verticale. Le controindicazioni di questa posizione fanno capo giustamente all’influenza della forza di gravità sul corpo del bambino. In fascia, la forza è contrastata in parte dalla tensione e dal sostegno del tessuto ma è assolutamente necessario sistemare i bambini in modo che il loro schema motorio risponda attivamente alla sollecitazione non ammortizzata dalla fascia (anche questo, in accordo con le più recenti indicazioni di prevenzione della SIDS emanate nel 2016).
Il babywearing può essere uno strumento prezioso per più motivi: il contatto nutre e stabilizza, il movimento passivo che il corpo del bambino fa sfruttando la mobilità muscolare del portatore facilita lo sviluppo muscolare e motorio del bambino, il ritmo respiratorio del portatore induce regolarità in quello del portato e la capacità di termoregolazione dell’adulto va a coinvolgere anche il neonato. Il sostegno della stoffa permette di mantenere le competenze da “portati attivi” dei neonati come ad esempio la capacità di aggrapparsi o di gestire il proprio corpo in modo costruttivo senza essere penalizzati troppo dalla forza di gravità.
La posizione, quando corretta, previene vizi posturali o piccole e medie patologie legate alla postura (displasia evolutiva, plagiocefalia, squilibrio tra destra e sinistra etc).
In particolare, studiosi di etologia come Wulf Schiefenhövel ed Evelin Kirkilionis, hanno soffermato la loro attenzione, sulla correlazione esistente tra salute dello sviluppo osteo-articolare e il portare in fascia.
Schiefenhövel parla del beneficio offerto dalla pressione della testa del femore nella cavità acetabolare durante il portare, che andrebbe a favorirne la maturazione.
Beneficio che grazie al continuo movimento favorirebbe il ritmo di crescita ossea.
La Kirkilionis ha descritto invece nei suoi studi come i bambini portati sul fianco, con appoggio sul bacino dei propri genitori, tendono ad assumere spontaneamente il fisiologico angolo di apertura delle anche, cioè quello migliore nella displasia congenita dell’anca. Si è visto inoltre, che bambini con displasia portati regolarmente dimostrano meno problemi con l’innalzamento dorsale del bacino, rispetto ai bambini che sono trattati solo il divaricatore.
Non possiamo, però, dimenticare che qualsiasi supporto o modo di portare per più corretto, naturale e spontaneo che sia, deve essere curato in funzione del neonato e delle sue caratteristiche fisiche, psichiche e relazionali peculiari.
Quindi portare in fascia assolutamente si, ma con criterio. Non si deve improvvisare e laddove ci fossero dei dubbi è sempre meglio rivolgersi ad un consulente formato e preparato.
Come sempre, è il modo che può fare la differenza dell’oggetto.
(Veronica)



 Siamo ormai sicuri che l’anno scolastico in corso, sospeso a causa dell’attuale epidemia, non terminerà dentro le aule. Tutto rimandato a Settembre, dunque. Il rebus che coltiva la preoccupazione dei genitori è costituito dal prevedere fin da ora come la scuola ricomincerà. Una commissione di esperti è infatti a lavoro per formulare le prime ipotesi a riguardo. Se per la ministra dell’istruzione Azzolina si potrà stare di nuovo dietro ai banchi solo in totale sicurezza e sulla base delle dichiarazioni del ministro della salute Speranza, la prossima fase 2 del contagio dovrà realizzarsi con estrema gradualità, risulta difficile immaginare il rientro in blocco di otto milioni di studenti dopo l’estate. Come risulta difficile pensare che, data l’età media degli insegnanti italiani, (la più alta in Europa secondo un’indagine OCSE del 2019) si possa chiedere di
Siamo ormai sicuri che l’anno scolastico in corso, sospeso a causa dell’attuale epidemia, non terminerà dentro le aule. Tutto rimandato a Settembre, dunque. Il rebus che coltiva la preoccupazione dei genitori è costituito dal prevedere fin da ora come la scuola ricomincerà. Una commissione di esperti è infatti a lavoro per formulare le prime ipotesi a riguardo. Se per la ministra dell’istruzione Azzolina si potrà stare di nuovo dietro ai banchi solo in totale sicurezza e sulla base delle dichiarazioni del ministro della salute Speranza, la prossima fase 2 del contagio dovrà realizzarsi con estrema gradualità, risulta difficile immaginare il rientro in blocco di otto milioni di studenti dopo l’estate. Come risulta difficile pensare che, data l’età media degli insegnanti italiani, (la più alta in Europa secondo un’indagine OCSE del 2019) si possa chiedere di
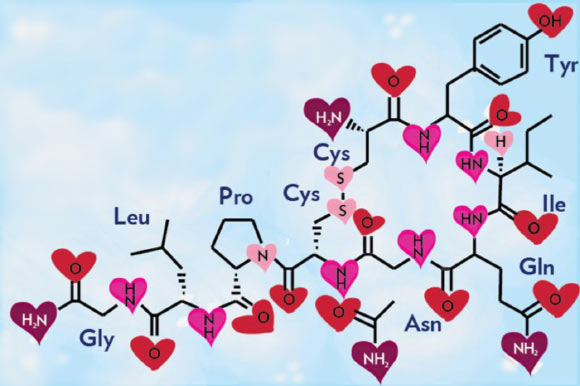










 Partite per tempo, coinvolgete i nonni nelle scelte di accudimento e nelle scelte pedagogiche, fate filtrare l’emozione attraverso le parole più distanti di qualcuno che è lì proprio per informare, sostenere, incoraggiare, offrire vie d’uscita. E poi, chissà, magari potrete provare a ricostruire quello che è rimasto incompleto.
Partite per tempo, coinvolgete i nonni nelle scelte di accudimento e nelle scelte pedagogiche, fate filtrare l’emozione attraverso le parole più distanti di qualcuno che è lì proprio per informare, sostenere, incoraggiare, offrire vie d’uscita. E poi, chissà, magari potrete provare a ricostruire quello che è rimasto incompleto.





